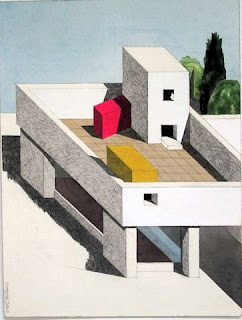«Molti
anni fa quando c'era ancora la grande Russia, che però cominciava a
scricchiolare, sono stato invitato a Varsavia a parlare con gli
studenti del politecnico e ci sono andato. Era quasi
inverno e a Varsavia faceva un freddo bestiale e mi hanno messo in un
albergo tutto perfetto, un po' come gli alberghi americani. Tipo
Hilton.
Quando
sono arrivato era notte e c'era un grande buio profondo perché tutte
le luci della città erano spente o quasi; niente vetrine
illuminate, niente neon delle pubblicità, niente fari o
riflettori vari. Anche le strade erano oscure, poco illuminate e
le auto pochissime. Fuori dalla finestra, dall'altra parte della
strada, nel buio vedevo un enorme palazzo nero, un palazzo
gigantesco, di pietra, con larghe scalinate, con portoni alti,
con moltissime colonne, grossi finestroni. Forse anche statue.
Tutto nero nel buio.
Quell'edificio
sembrava un'apparizione, un fantasma, giustificato soltanto dal
freddo del Nord, dalla notte senza luci e anche dall'assenza
di
abitanti. Che cosa avrebbero potuto fare gli abitanti lì dentro?
Parlare sottovoce? Dedicarsi alle torture? Gli abitanti erano
tutti scappati? Quando ho chiesto perché c'era quell'edificio e a
che cosa serviva, mi hanno detto: « È un regalo della Russia
alla Polonia ». Poi uno studente ha detto: « In Russia, al
politecnico c'è una facoltà dove si studia soltanto
l'architettura monumentale ».
 |
|
Anche
a Hong Kong, anche a Tokyo, anche nelle metropoli americane, anche a
Brasilia, le notti cittadine sono più o meno così: i grattacieli
sono abbandonati al buio, le banche sono o-scure, le finestre degli
uffici deserte, i musei sprangati; sono chiusi i giornalai, i
tabaccai e le autorimesse alte venti, trenta piani, sono scheletri
di cemento senza senso. Gli edifici per concerti, congressi,
spettacoli, discorsi politici e cose del genere hanno vita
provvisoria. Per qualche istante sono circondati da vaste distese di
parcheggi di lamiera e poi, quando le lamiere se ne vanno, quei
grandiosi edifici stanno immobili, in silenzio, come fantasmi morti
sul colpo, circondati da spazi deserti con le righe bianche per «
posti macchina ».
Qualunque
destino insegua il potere e qualunque forma il potere finisca
per assumere non può fare a meno di sventolare bandiere
gigantesche, innalzare campanili, templi e cattedrali altissime,
torri, ziggurat, piramidi: non può fare a meno di impossessarsi di
spazi vasti, di dimensioni esagerate, non può fare a meno di
segnalare la propria presenza, la propria potenza, la propria
ineluttabilità, la propria eternità. Dal fantasma di qualche specie
di potere, di qualche tribù che invocando Dio o la Patria o la nuova
società riesce a dire alle altre tribù che cosa devono fare, che
cosa devono sperare, che cosa devono odiare, non c'è modo di
liberarsi. Le scuole dove si studia attentamente come progettare
l'architettura monumentale, dove gli architetti diventano compiici
dei programmi del potere, ci saranno sempre e le storie
dell'architettura parleranno sempre di architetture monumentali.
E così sia.

Mi
sono domandato: «Perché la storia dell'architettura si occupa
soltanto di monumenti? Forse perché i monumenti sono sempre pensati
così giganteschi che resistono nel tempo? « Perché la storia
dell'architettura si occupa soltanto o specialmente dei segni
che i poteri hanno lasciato di se stessi? ».
Forse
perché i segni del potere sono specialmente rispettati data la
paura che il potere continua a trasmettere anche quando è il
rudere di se stesso? Anche dopo morto? Perché la storia
dell'architettura non si occupa dei milioni e milioni e milioni di
case e casette allineate lungo le strade tra un paese e l'altro o
allineate per fare strade corte e piazze o sparse a popolare colline,
montagne, valli, rive dei mari e rive dei laghi?
Mi
sono messo a pensare che l'architettura di una nazione, di un popolo,
di un momento, non è necessariamente disegnata dai dieci o venti o
cinquanta monumenti - o tombe - che i poteri di passaggio hanno
gentilmente pagato per lasciare la loro memoria che non è la
memoria delle infinite vite della gente, delle infinite ore
passate dovunque dalla gente a cercare di sopravvivere, passate
a domandarsi perché, come, quando, a domandarsi ogni giorno che
cosa succederà domani. Forse l'architettura di una nazione, quella
sparsa
nelle valli, sulle colline, sulle spiagge, lungo le strade, nei
paesi, è disegnata dalla presenza delle mille e mille case e
casette, ville, villette e villone che sono progettate e costruite
per vivere, sono pensate per la vita che si vive dalla mattina
alla sera e sono anche pensate - se così deve succedere - per
l'oblio; non sono certo pensate per lasciare memoria. Sono
circondate da giardinetti o giardini e non necessariamente da parchi.
Anzi, come ho visto in Cina sono circondate da orti piccoli con
insalate di un verde speciale fosforescente, con cavoli viola e
fiori rosa e bianchi di piselli.

I
paesi delle isole greche sono paesi delle isole greche perché ci
sono le casette. Non c'è il Partenone.
Anche
il Giappone è - o era - disegnato di migliaia di casette con il
tetto di ceramica blu, immerse nelle foreste di bambù che
ondeggiano sempre. Non ci sono gli imponenti templi di Nara.
Anche
l'architettura della California ha rischiato di essere disegnata
dalle casette, milioni di casette di legno che si possono portare di
qua e di là e poi casette progettate da architetti delle facoltà
dove si insegna a fare casette, progettate da
Neutra, da Mies, da Eames, da Frank Lloyd Wright, ecc.
Anche
il Bronx è disegnato da mille case e casette abbandonate, con
le porte inchiodate, le saracinesche arrugginite, i vetri opachi,
grigi di polvere.
Anche
a Bahia nel Sertào l'architettura è fatta di casette, casette
dipinte dalle donne, casette di tutti i colori, tutte in fila a fare
strade di famiglia. Non c'è la cattedrale di San Salvador...
Perché
l'Architettura monumentale non si degna mai o quasi mai di
guardare quell'altra gigantesca architettura che è disegnata
dalla somma delle architetture di tutte le case, casette,
fabbriche e fabbrichette, alberghetti e pensioni? Perché quelli
che sanno queste cose, quelli che gestiscono il «design
management», «l'architettura monumentale management», il
management in generale, non organizzano facoltà nelle quali si
pensa soltanto all'architettura come somma delle architetture
delle case, casette, fabbriche, fabbrichette, alberghetti e
pensioni? Facoltà dove si pensi soltanto al destino delle generali
architetture attenuate, metafora del reale stato di salute o malattia
delle società?»